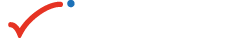SEI IN HOME / Blog / Disturbi Specifici dell'Apprendimento / La grande fabbrica delle parole: comunicare tra abitudine e consapevolezza
La grande fabbrica delle parole: comunicare tra abitudine e consapevolezza

- Argomenti: Disturbi Specifici dell'Apprendimento
Introduzione
Immagina un mondo in cui le parole hanno un prezzo.
Un mondo in cui parlare non è scontato, ma un privilegio per pochi.

È lo scenario raccontato nell’albo illustrato La grande fabbrica delle parole di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo: una fiaba moderna e poetica, che ci accompagna in una riflessione profonda sul valore del linguaggio e sul senso autentico del comunicare.
Questo racconto diventa una potente metafora per chiederci: comunicare è davvero solo un atto spontaneo e quotidiano, oppure una sfida che richiede intenzionalità, ascolto e grande consapevolezza?
Attraverso le immagini simboliche dell’albo e i principali modelli teorici della comunicazione, andremo a esplorare come parole e silenzi siano strumenti alla base di ogni relazione.
Il mondo della grande fabbrica: metafora della comunicazione umana
Nel paese della grande fabbrica delle parole, parlare non è un diritto universale: le parole si comprano, si conservano, si scelgono con cura. Alcune costano molto, altre poco. Alcune sono rare, altre comuni. I più ricchi possono dire tutto, i più poveri quasi nulla. In questo contesto vive Philéas, un bambino che ha poche parole a disposizione, ma un grande desiderio: esprimere ciò che sente per Cybelle.
Questo scenario surreale riflette una verità profondissima: le parole non sono tutte uguali. Ogni atto comunicativo è fatto di scelte:
Cosa vogliamo dire? Con che intenzione? A quale scopo?
Qui entra in gioco il modello teorico di Roman Jakobson, che individua sei componenti fondamentali della comunicazione: mittente, messaggio, destinatario, codice, contesto e canale. Quando uno di questi elementi non funziona correttamente, la comunicazione si interrompe, si distorce o perde efficacia. Ogni intoppo genera effetti diversi e può portare a fraintendimenti, conflitti o incomprensioni.

Essere consapevoli di questi punti critici aiuta a prevenire malintesi, a costruire relazioni più solide e a migliorare la qualità della comunicazione, specialmente nei contesti educativi, relazionali e professionali, ma anche in quelli familiari.
Comunicare con cura: parole scelte e linguaggio del corpo
Philéas ha poche parole, quindi deve scegliere con attenzione. Questo ci insegna che comunicare non significa semplicemente parlare, ma scegliere cosa dire, come dirlo, quando e a chi.
Questa è l’essenza della comunicazione assertiva, che si basa sulla capacità di esprimere i propri pensieri e sentimenti con chiarezza, rispetto e autenticità.

Ogni persona comunica in modo diverso. I principali stili comunicativi sono:
- Comunicazione assertiva: esprime in modo chiaro e rispettoso i propri bisogni e opinioni. Favorisce relazioni sane e gestione positiva dei conflitti.
Esempio: “Capisco il tuo punto di vista, ma per me è importante parlarne insieme.” - Comunicazione aggressiva: esprime in maniera sicura il proprio punto di vista senza se e senza ma, probabilmente interromperà di frequente le discussioni per esprimere le proprie idee usando frasi provocatorie. Dal punto di vista della comunicazione non verbale, tende a guardare insistentemente l’interlocutore negli occhi.
Esempio: “Hai torto” o “Non hai capito”. - Comunicazione passiva: evita il conflitto, reprime le emozioni, fatica a dire “no”. Porta spesso a frustrazione e relazioni sbilanciate.
Esempio: “Va bene… come vuoi tu…” (anche se non lo pensa davvero). - Comunicazione passivo-aggressiva: esprime disaccordo in modo indiretto o ambiguo, con sarcasmo o atteggiamenti contraddittori. Crea confusione e tensioni.
Esempio: “Certo, fai pure… tanto la mia opinione non conta mai…“
Nel libro, Philéas incarna la comunicazione assertiva: dice poco, ma con sincerità e presenza, esprimendo con autenticità ciò che prova.
Comunicare davvero: tra disuguaglianze e qualità relazionale
Nel paese della grande fabbrica delle parole, chi ha più soldi può permettersi parole rare, importanti, poetiche. Gli altri si accontentano di termini comuni, raccolti per caso.
Questa immagine forte richiama una realtà che conosciamo bene: anche nel nostro mondo, non tutti hanno pari accesso alla comunicazione. Differenze culturali, sociali, economiche o educative possono ostacolare la possibilità di esprimersi, farsi comprendere e ascoltare. In termini comunicativi, queste disuguaglianze funzionano come un rumore di fondo che distorce il messaggio, compromettendo la relazione.
Eppure, come insegna Philéas, non serve dire tanto per dire bene.
Nel libro lui usa tre parole: ciliegia, seggiola, polvere. Non vogliono dire niente, ma comunicano tutto.
È quindi la qualità del messaggio a fare la differenza. Le funzioni emotiva e referenziale della comunicazione – teorizzate da Jakobson – ci ricordano che un messaggio è davvero efficace quando tocca, informa e soprattutto connette.
In una società in cui si parla molto ma si comunica poco, scegliere di comunicare in modo consapevole è un gesto di responsabilità, di cura e di giustizia. Saper comunicare significa anche costruire ponti, ridurre distanze e riconoscere il valore dell’altro.
Conclusioni
La grande fabbrica delle parole ci ricorda che le parole hanno un valore, non solo in senso economico, ma emotivo, relazionale e sociale. Scegliere cosa dire significa scegliere come stare con gli altri.
Ogni giorno, in ogni relazione, possiamo chiederci: sto parlando per abitudine o per scelta? Sto ascoltando davvero? Sto costruendo o sto riempiendo il silenzio?
Comunicare è molto più che emettere suoni, è un atto umano profondo, che può ferire o guarire, unire o separare. A noi la scelta.
Bibliografia
- De Lestrade, A., & Docampo, V. (2010). La grande fabbrica delle parole. Terre di Mezzo.
- Jakobson, R. (1960). Linguistica e poetica, in Saggi di linguistica generale. Feltrinelli.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press.
- Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In Bryson, L. (Ed.), The Communication of Ideas.
- Simona Rattà (2021). La comunicazione efficace. FrancoAngeli.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967). Pragmatica della comunicazione umana. Astrolabio
A cura di: Chiara Tomesani – Psicologa del Centro di Apprendimento Anastasis