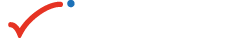SEI IN HOME / Blog / Disturbi Specifici dell'Apprendimento / Funzioni Esecutive e DSA: come influenzano lo sviluppo e l’apprendimento
Funzioni Esecutive e DSA: come influenzano lo sviluppo e l’apprendimento

- Argomenti: Disturbi Specifici dell'Apprendimento
Cosa sono le Funzioni Esecutive?
Le Funzioni Esecutive (FE) rappresentano un insieme di processi cognitivi di ordine superiore che permettono di pianificare, organizzare, regolare e monitorare il comportamento e il pensiero. Tra queste troviamo l’inibizione, la memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva, la pianificazione, l’autocontrollo, e la regolazione delle emozioni. Queste abilità non sono innate in forma completa, ma si sviluppano progressivamente a partire dalla prima infanzia e maturano durante l’età scolare e oltre.
Le FE si collocano al crocevia tra cognizione e comportamento, giocando un ruolo cruciale nell’autoregolazione e nell’adattamento alle richieste ambientali e scolastiche. Sono quindi essenziali non solo per l’apprendimento, ma anche per la partecipazione attiva, efficace e consapevole alla vita quotidiana.
L’importanza dello sviluppo precoce delle FE
Le ricerche più recenti indicano che è possibile osservare e stimolare precocemente le FE già in età prescolare. In questa fase, attraverso attività ludiche, interazioni sociali e proposte educative mirate, i bambini iniziano a esercitare forme rudimentali di controllo dell’attenzione, memoria di lavoro e capacità di inibizione.
Il potenziamento precoce delle FE è associato a migliori esiti scolastici futuri, in quanto queste funzioni supportano l’acquisizione di prerequisiti fondamentali per la letto-scrittura e la cognizione numerica. Attività che promuovono l’autoregolazione, come i giochi di ruolo, il gioco simbolico o compiti con regole da seguire, sono strumenti efficaci in contesti educativi e terapeutici.
Funzioni esecutive e apprendimento: un legame stretto
Nel contesto scolastico, le FE diventano sempre più determinanti per affrontare compiti complessi come leggere, scrivere e calcolare. Ad esempio, la memoria di lavoro consente al bambino di trattenere e manipolare le informazioni mentre legge un testo o risolve un problema matematico; l’inibizione permette di evitare distrazioni e risposte impulsive; la pianificazione è necessaria per organizzare un testo scritto o un’esposizione orale.
Una debolezza in questi ambiti può ostacolare significativamente l’apprendimento, anche in assenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Tuttavia, quando le difficoltà esecutive coesistono con un DSA, possono amplificarne l’impatto e rendere più complesso l’intervento educativo e riabilitativo.
Le Funzioni Esecutive come predittori dei DSA
Le ricerche più recenti nel campo della neuropsicologia dello sviluppo suggeriscono che le Funzioni Esecutive possono rappresentare indicatori precoci di rischio per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Ad esempio, la memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale è strettamente coinvolta nei processi di decodifica e comprensione del testo. Un bambino che fatica a trattenere e manipolare mentalmente le informazioni mostrerà difficoltà nel legare i suoni alle lettere (processo fonologico), nel comprendere frasi complesse o nel risolvere problemi aritmetici. La flessibilità cognitiva, invece, è fondamentale per passare da una regola all’altra, come accade quando si affrontano eccezioni ortografiche o strategie matematiche alternative. L’inibizione gioca un ruolo centrale nel controllo delle risposte impulsive, molto rilevante nelle fasi iniziali dell’apprendimento della lettura e della scrittura.
Sebbene i DSA siano classificati come disturbi neuroevolutivi con una base genetica e biologica, il profilo esecutivo può modulare la gravità del quadro clinico e il modo in cui il bambino affronta le proprie difficoltà. Diversi studi longitudinali (es. Usai et al., 2014; Diamond, 2013) hanno mostrato che bambini in età prescolare con difficoltà significative in una o più FE presentano un rischio più elevato di sviluppare DSA. Questi bambini possono mostrare un approccio più disorganizzato ai compiti, una scarsa capacità di automonitoraggio e maggiori difficoltà a mantenere l’attenzione su compiti cognitivamente impegnativi.
Un’adeguata valutazione delle FE in età prescolare e nei primi anni della scuola primaria può quindi rappresentare uno strumento predittivo e preventivo, capace di individuare precocemente profili di rischio e orientare l’intervento in ottica di prevenzione secondaria.
Intervenire sulle FE nei bambini con DSA
L’intervento sulle Funzioni Esecutive nei bambini con DSA si configura come un complemento essenziale alle attività specifiche di potenziamento delle abilità scolastiche. Rinforzare l’efficienza delle FE significa migliorare indirettamente anche l’accesso e l’utilizzo delle competenze di lettura, scrittura e calcolo.
Molti programmi educativi e riabilitativi efficaci includono esercizi mirati per potenziare l’attenzione sostenuta, la memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva e la pianificazione. Tuttavia, anche in contesti quotidiani non clinici, come quello familiare, è possibile sostenere lo sviluppo esecutivo attraverso attività semplici e significative.
Ad esempio, per allenare la memoria di lavoro, possono essere proposte sequenze da ripetere o manipolare (come ricordare una lista di parole e poi riportarla al contrario). Per stimolare l’inibizione e il controllo dell’impulsività, sono utili giochi che richiedano di modificare la risposta abituale, come dire l’opposto di quanto richiesto (“se dico ‘giorno’, rispondi ‘notte’”). La pianificazione può essere incoraggiata coinvolgendo il bambino nell’organizzazione di attività quotidiane, come preparare una ricetta o pianificare il pomeriggio attraverso un’agenda visiva. La flessibilità cognitiva, infine, può essere esercitata con attività che richiedono cambi di prospettiva, come inventare finali alternativi a una storia nota o raggruppare oggetti secondo criteri diversi.
Queste attività, se proposte con regolarità e gradualità, favoriscono lo sviluppo delle FE anche in bambini con DSA, migliorando la loro autonomia, la capacità di gestione dei compiti scolastici e la fiducia in sé stessi. È importante che il clima in cui si svolgono sia positivo, motivante e non giudicante, per promuovere un apprendimento efficace e duraturo.
Oltre alle attività pratiche dirette, è fondamentale enfatizzare l’insegnamento di strategie metacognitive. Queste strategie aiutano i bambini a diventare più consapevoli dei propri processi di pensiero e di come utilizzare al meglio le proprie Funzioni Esecutive per affrontare i compiti. Non si tratta solo di “fare”, ma di “riflettere su come si fa”. Ad esempio, incoraggiare un bambino a “pensare a voce alta” mentre risolve un problema di matematica può aiutarlo a monitorare il proprio ragionamento, identificare errori e trovare soluzioni alternative. Allo stesso modo, insegnargli a “controllare il proprio lavoro prima di consegnarlo” stimola l’automonitoraggio e l’autocorrezione, aspetti chiave dell’autoregolazione. Questo approccio potenzia non solo le abilità specifiche, ma anche la capacità del bambino di gestire in modo autonomo il proprio apprendimento, rendendolo più efficace e consapevole.
Tali strategie, se condivise anche in ambito scolastico e familiare, permettono di creare una rete educativa coesa e centrata sull’autonomia del bambino. Sostenere lo sviluppo delle Funzioni Esecutive non significa solo intervenire sulle difficoltà, ma offrire a ogni bambino strumenti per crescere con consapevolezza, fiducia e competenza.
Bibliografia
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
- Giofrè, D., Mammarella, I. C., Ronconi, L., & Cornoldi, C. (2014). Visuospatial working memory and mathematical abilities: A latent-variable approach. Intelligence, 42, 1–10.
- Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). The role of intelligence and working memory in reading and reading comprehension. Learning and Individual Differences, 38, 92–99.
- Henry, L. A., Messer, D. J., & Nash, G. (2012). Executive functioning in children with specific language impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(1), 37–45.
- Usai, M. C., Viterbori, P., Traverso, L., & De Franchis, V. (2014). Latent structure of executive function in five-and six-year-old children: A longitudinal study. European Journal of Developmental Psychology, 11(4), 447–462.
- Cornoldi, C., & Giofrè, D. (2014). Le difficoltà di apprendimento. Bologna: Il Mulino.
A cura di: Elisa Carli – Psicologa e Direttrice del Centro di Apprendimento Anastasis
Webinar
Le Funzioni Esecutive (FE) quali memoria di lavoro, controllo dell’interferenza, flessibilità cognitiva e capacità di inibizione, sono abilità cognitive fondamentali che stanno alla base di molti comportamenti e apprendimenti. Quando...
- Funzioni Esecutive, Mondo degli Elli, Potenziamento, Scuola
- Lun 27 Mag '24
- 17:00 -
- 18:00
In questo webinar esploreremo le funzionalità di un innovativo modello educativo che utilizza un videogame in combinazione con attività di gruppo e momenti di riflessione metacognitiva: una piattaforma progettata per...
- Funzioni Esecutive, Mondo degli Elli, Potenziamento, Scuola
- Mar 07 Mag '24
- 17:00 -
- 18:00